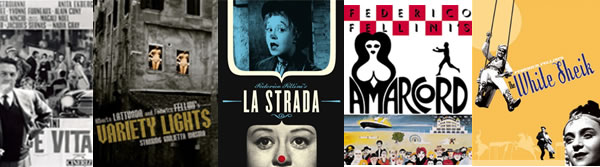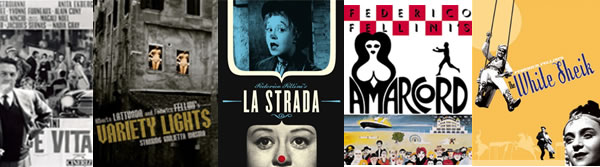5.2 Guerra di trincea
5.2.1 La poesia dei vagabondi
Il copione de La strada nasce dall'amore che sia Fellini che Pinelli nutrono nei confronti dei vagabondi. Non è, tuttavia, chiaro di chi sia stato lo spunto iniziale. Tullio Kezich attribuisce l'idea a Fellini che avrebbe incontrato una famiglia di zingari somiglianti a Zampanò e Gelsomina durante le riprese di Luci del varietà. Pinelli, invece, racconta di aver incontrato i due personaggi durante un viaggio in cui, in macchina, si recava a far visita alla sua famiglia, rimasta a Torino. A onor del vero lo stesso Pinelli aggiunge poi che anche Fellini aveva il desiderio di girare qualcosa sui vagabondi e che dunque la lavorazione li vide perfettamente concordi, nonostante il dissenso di Flaiano che riteneva l'idea una sciocchezza.
La gestazione del film è stata, comunque, piuttosto lunga. Pinelli inizia, infatti, a stendere la sceneggiatura durante le riprese de I vitelloni e dopo quest'opera Fellini realizza anche le riprese dell'episodio che figurerà nel manifesto neorealista Amore in città.
Nel frattempo Fellini fatica ad imporre la Masina come protagonista. I produttori non credono in lei e più di una volta cercano di convincerlo a non utilizzarla proponendogli altre attrici più affermate come Silvana Mangano. Fellini rifiuta decisamente e continua a reclutare il cast basandosi solo sul suo istinto. I due protagonisti maschili sono notati sul set di altri film in lavorazione a Cinecittà, Basehart è poi sposato con Valentina Cortese e vive costantemente sotto i riflettori dei paparazzi che verranno poi fedelmente riprodotti in La dolce vita.
L'invasione del cinema made in USA sta raggiungendo il suo apice e, di conseguenza, aumenta l'interesse dei mass media nei confronti del jet-set e degli scandali con cui esso convive. Ma Fellini non è sufficientemente rinomato per essere ancora il bersaglio dei reporter. La lavorazione del film procede lentamente e con grossi problemi organizzativi dovuti al fatto che il film si realizza quasi esclusivamente in esterni. Inoltre la Masina si infortuna dopo poche settimane di riprese. In più, verso la fine delle riprese, lo stress fa cadere il regista in una strana forma di depressione. La guarigione da questo disturbo psichico viene interpretata da Kezich come un momento determinante per la maturazione dell'uomo e dell'autore.
5.2.2 A Venezia equivoci e falsi dualismi
La prima avviene al Festival di Venezia il 6 settembre 1954 in un'atmosfera nervosa. Gira infatti la voce che ambienti politici stiano boicottando l'opera di Luchino Visconti Senso, considerato in quel periodo il leader della cinematografia marxista. In contrapposizione al rappresentante della sinistra, Fellini viene adottato dalla stampa cattolica e borghese come proprio campione in virtù dei contenuti più spirituali delle pellicole del regista romagnolo. Nasce così un falso dualismo, che durerà una decina d'anni, alimentato ad arte dalla stampa e dai media, tra due registi che nulla hanno in comune con le divisioni politiche e ideologiche del periodo che sono alla base della polemica.
L'equivoco viscontiano è generato dalla realizzazione de La terra trema che viene additato quale esempio di perfetto neorealismo, trascurando, invece, le ispirazioni pittoriche e letterarie alla base non solo del film in questione ma di tutta l'opera di Visconti. Abbiamo già visto, inoltre, come anche Fellini non sia mai stato particolarmente amato dalla critica cattolica e non lo sarà neppure negli anni successivi a La dolce vita e che dunque il suo utilizzo come simbolo del cinema spirituale e cattolico era del tutto strumentale.
La contestazione alla premiazione del festival che vede Fellini premiato con il Leone d'argento - quello d'oro è stato assegnato a Giulietta e Romeo di Castellani - e Senso completamente escluso da ogni tipo di riconoscimento, provoca una gazzarra sedata solo grazie all'intervento della polizia. Inoltre l'amarezza per il boicottaggio subito, spinge Visconti a rilasciare dichiarazioni abbastanza dure nei confronti dell'opera di Fellini. I due, dopo un periodo di freddezza reciproca durato anni, si riappacificano a Mosca durante il festival omonimo del 1963.
Questa contrapposizione è alimentata anche dalla rivalità esistente tra le due "corti" che vivevano a fianco dei registi. Visconti era, infatti, "un signore rinascimentale che aveva una corte di cui la sinistra era il lusso, la ciliegina sulla torta. Prima veniva l'aristocrazia, poi l'estetismo e, infine, il comunismo". Anche attorno alla figura di Fellini ruotava una struttura che si potrebbe definire anch'essa cortigiana al pari di quella viscontiana. Per cui non è difficile immaginare che gelosie, invidie e divisioni ideologiche tra le due realtà abbiano giocato un ruolo importante nella presunta inimicizia tra i due autori.
E' probabile comunque che questa contrapposizione sia servita a molti per mascherare l'avversione profonda per la pellicola felliniana bollata in Italia come traditrice della causa neorealista. Se Pasolini la definisce un capolavoro, molti critici si affannano a cercare difetti e imperfezioni. Se, nell'Italia degli anni '50, il potere è a destra, la cultura, egemonizzata dalla sinistra, si situa in una dura opposizione che non accetta i tentativi di affrancarsi da questa visione manichea della società. E' da segnalare che il fenomeno ha assunto dimensioni abnormi soprattutto in Italia come dimostra la recensione moderatamente positiva che George Sadoul, santone della critica marxista mondiale e noto per la sua feroce avversione verso il cinema da lui ritenuto borghese e commerciale, fa di La strada.
In Italia, invece, la critica si scatena contro Fellini accusandolo di volta in volta di essersi ispirato a "deteriore letteratura" o di insincerità (si possono citare, tra gli altri, Pasquale Ojetti, Gaetano Strazzulla, Lino Del Fra'). Qualcuno, come G. Marotta su L'Europeo, bolla il film come improbabile e, preso da un impulso irrefrenabile di stupidità, deride chi afferma che "si tratta della tragedia dell'incomunicabilità fra le creature" poiché, secondo lui, "la effettiva tragedia dell'incomunicabilità è solo quella in atto fra individui normali, pieni di intelligenza, di educazione, di sensibilità" e non tra "un bruto e una deficiente" che "è ovvio non abbiano un bel niente da comunicarsi."
I rilievi più articolati gli vengono mossi da due mostri sacri della critica militante italiana: Guido Aristarco e Luigi Chiarini. Il primo afferma che "Fellini è un regista anacronistico irretito com'è in problemi e dimensioni umane largamente superate. [..] E' rimasto alla letteratura d'anteguerra, cerca giustificazioni e resta adolescente” . Il secondo ritiene che "i personaggi ridotti a simboli sono svuotati di una loro concreta e possibile umanità. [..] Mancando delle persone vengono a cadere i problemi su di esse astrattamente imperniati. I personaggi non sono immersi nella realtà." Ci mette del suo anche il CCC che emette il seguente giudizio "La difficoltà di un'esatta comprensione del film da parte di un pubblico giovanile e l'assenza di freni morali nel protagonista consigliano di riservare la visione agli adulti."
Nonostante la evidente opposizione della critica che tende a privilegiare l'assunto sociale sui contenuti morali di un film a forma di favola, La strada riscuote un buon successo nelle sale. Alla fine della stagione 54/55 la classifica degli incassi la pone al 17esimo posto con un introito pari a 430 milioni. Ma il vero successo la pellicola la coglie all'estero, trionfando quasi ovunque fino a cogliere l'Oscar per il miglior film straniero nel 1956. Oltre all'ambita statuetta, la fiaba di Gelsomina è premiata in tutto il mondo. La Danimarca lo considera il miglior film dell'anno; in Belgio gli viene riconosciuto il premio della critica. Persino in Giappone Fellini viene consacrato maestro del cinema; a New York stabilisce il record di visioni superando i due anni di programmazione e incassando la bellezza di 650 milioni. Questo successo non scalfisce minimamente le convinzioni della critica italiana che, anzi, ironizza sul ritardo culturale del resto del mondo
|