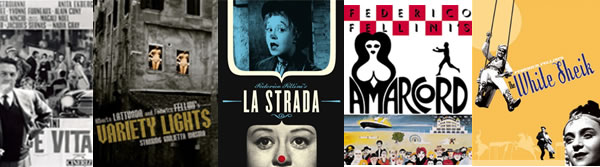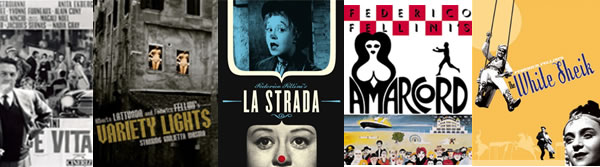4.2 Da sogno a sogno
4.2.1 Sfaccendati di provincia
Nel dizionario Il nuovo Zingarelli il termine "vitellone" viene definito: "Giovane che trascorre il tempo oziando o in modo vacuo e frivolo, senza cercare di uscire da un ambiente sociale mediocre e privo di stimoli intellettuali". E' un neologismo coniato proprio dal titolo della terza opera registica di Fellini. Non sarà l'unico caso in cui il cineasta romagnolo conierà parole che poi entreranno a far parte del linguaggio quotidiano (Paparazzo e Dolce vita saranno i casi più eclatanti). La provenienza di questo vocabolo è ancora poco chiara; si dice che derivi dal dialetto riminese "vidlòn", espressione con cui i contadini indicavano gli studenti e in genere gli sfaccendati. Un'altra ipotesi lo fa invece derivare dal dialetto marchigiano ed utilizzato nel lessico familiare di Ennio Flaiano che ne discetta l'origine in una sua lettera del 1971: "il termine era usato ai miei tempi per indicare un giovane di famiglia modesta, magari studente, ma o fuori corso o sfaccendato... Credo che sia una corruzione di vudellone, un grosso budello, persona portata alle grosse mangiate e passato in famiglia a indicare che mangia a ufo, che non produce, un budellone da riempire."
Con questa opera Fellini raffigura la realtà di una parte della provincia italiana mettendo contemporaneamente in scena il disagio che coglie i giovani che si affacciano al mondo del lavoro. Se per il ragazzino, l'amico di Moraldo figlio di un ferroviere, è assolutamente normale iniziare a lavorare a 14 anni; per gli sfaccendati piccoli borghesi che si aggirano per questa Rimini fantastica, frutto delle riprese effettuate in diversi luoghi d'Italia, il lavoro è uno spettro che disturba i loro sogni adolescenziali e li vuole costringere a prendersi carico delle responsabilità della vita.
Come e più delle altre opere vi è una forte connotazione biografica nei personaggi rappresentati e soprattutto nell'alter ego del regista. Ma sul fatto che i vitelloni fossero un fenomeno tipico della provincia non solo italiana, ma mondiale non esistono dubbi. Non si spiegherebbe, diversamente, il forte impatto emotivo che il film ha avuto sul pubblico e sui registi di tutto il mondo che lo hanno preso come modello. I casi più famosi, elencarli tutti sarebbe impossibile, sono: Calle Mayor (1956) dello spagnolo J. Bardem, I basilischi (1963) di Lina Wertmuller, Mean Streets (1973) di Martin Scorsese e American graffiti (1974) di George Lucas.
La lavorazione del film è piuttosto travagliata. I soldi sono pochi e, in aggiunta, Sordi, voluto fortemente da Fellini nonostante fosse, nelle considerazioni dei produttori, un attore odiato dal pubblico, è impegnato in teatro con la rivista di Wanda Osiris. L'inseguimento a Sordi porta la troupe a girare alcune scene a Viterbo (il veglione di Carnevale) e a Firenze (il negozio dell'antiquario). Anche l'inquadratura che ci propone i vitelloni che guardano dal pontile il mare d'inverno non è stata girata sulla riviera adriatica ma sul lungomare di Ostia. Oltre a Sordi, che da quel momento si impone invece come uno dei personaggi più amati del grande schermo, caratterizzato proprio dal personaggio "codardo, infido e adolescenziale cronico" che lo renderà famoso e così peculiarmente "italiano", Fellini riesce ad imporre alla produzione anche la scelta di Franco Fabrizi nel ruolo di Fausto (doppiato però da Nino Manfredi), che aveva notato tra i boys di Wanda Osiris. Il cast è poi completato dall'ex ragazzo prodigio Franco Interlenghi (salito alla cronaca con il ruolo da protagonista in Sciuscià), dal già conosciuto Leopoldo Trieste e da una serie di caratteristi provenienti dal teatro (Paola Borboni, Enrico Viarisio), dal fratello di Fellini, Riccardo, e da una diva del terzo reich, la cecoslovacca Lyda Baarova, nota per essere stata l'amante di Goebbels e, a causa di questo, per essere stata perseguitata da Hitler prima e dall'esercito sovietico poi.
La sfiducia verso la pellicola aumenta nei produttori a mano a mano che si avvicina il momento della fine delle riprese. Il produttore Pegoraro, dopo aver visto il materiale girato, si affretta a mettere in cantiere un film di sicuro esito commerciale che dovrebbe così permettergli di superare il previsto insuccesso de I vitelloni. I risultati del botteghino smentiranno ampiamente le previsioni; mentre Scampolo '53 (così si chiama la disgraziata pellicola “riparatrice”) è un disastro assoluto, il film di Fellini, a sorpresa, diventa uno dei successi della stagione. Incassa infatti nel 1953-54 ben 555 milioni e si piazza al nono posto della classifica delle pellicole italiane. Il notevole risultato commerciale è poi rafforzato dalla distribuzione all'estero dove I vitelloni spopola. In Argentina è campione d'incassi nel 1954, in Francia, Inghilterra e USA riscuote buoni consensi.
Il successo è aiutato anche dall'affermazione ottenuta al Festival di Venezia del 1953 dove la giuria, presieduta da Eugenio Montale, gli assegna il Leone d'argento insieme ad altre cinque pellicole in un palmarès in cui il massimo premio non è stato attribuito ad alcun film.
La critica italiana esprime, però, riserve sull'ultima fatica di Fellini. Pur non negando la validità dell'opera e le potenzialità del regista, essa pretende dal cinema la corretta formulazione dei problemi sociali e un aiuto per la soluzione degli stessi. Così Fernaldo Di Giammatteo scrive sulla rivista Rassegna del film: "E' indubbio che questo film svela una personalità nuova ed abbastanza autentica, ma è pure indubbio che le doti di questa personalità restino tuttora vaghe." Santarelli sulla Rivista del cinematografo osserva che "Fellini non ha lo spirito caustico della satira così come non ha lo spirito polemico della denuncia." Moravia, critico allora dell'Europeo,pur non disprezzando l'opera segnala che "Tutte queste figure sono disegnate sulla falsariga di un mondo provinciale di marca deamicisiana per nulla convincente." Non è da meno la recensione di Filippo Sacchi che, dalle pagine di Epoca, segnala che il personaggio di Moraldo (chiamato erroneamente Monaldo all'interno dell'articolo) è "assolutamente sbagliato nella sua uggiosa passività" facendo casualmente suo, sia pure partendo da basi diverse, il giudizio del CCC che esprime le proprie riserve sentenziando: "La condanna di un sistema di vita poco lodevole non è espressa con sufficiente chiarezza. Tale errore d'impostazione e la presenza di situazioni e scene scabrose fanno riservare la visione agli adulti di piena maturità morale." Altre critiche esprimono consenso all'opera sottolineandone il realismo. Angelo Solmi, su Oggi, dice che "Fellini [..] ci ha dato un ritratto esattissimo della vita di certa società di provincia", Vito Pandolfo esprime la convinzione che "Fellini [....] possiede la capacità di rievocare un ambiente e di metterne a fuoco le scottanti alternative, le asprezza di quella vita e la debolezza congenita di certi strati sociali."
|